I colori della rivolta
Le radici dell’indipendentismo veneto in uno spaccato dell’Italia dei bordi, dalle pagine del romanzo Una rivolta
“Brigata mona”. Così gli uomini vicini a Umberto Bossi, l’allora segretario della Lega Nord, qualificarono il commando di indipendentisti veneti che nella notte del 9 maggio 1997 invasero piazza San Marco, a Venezia, con un “Tanko” – un carrarmato artigianale ricavato da un trattore – e salirono sul campanile per issare la bandiera marciana, con il leone alato simbolo della Repubblica di Venezia. Il loro piano era occupare il campanile fino al 12 maggio, giorno in cui sarebbe ricorso il bicentenario della caduta della Repubblica veneta. Ribattezzati dalla stampa “i Serenissimi”, il loro gesto era da considerarsi come l’effetto di una grave delusione politica, che non riguardava tanto lo Stato italiano, «marcio oltre ogni limite», quanto piuttosto i movimenti autonomisti in cui militavano, che non stavano facendo abbastanza per l’autodeterminazione del Veneto.
L’accaduto del 9 maggio ’97 lascia ancora oggi sconcertati, e persiste la tendenza a bollare il gesto come ridicolo, patetico, surreale. Come sottolinea Paolo Rumiz nel suo saggio La secessione leggera – Dove nasce la rabbia del profondo Nord (Feltrinelli, 2001), nemmeno la stampa ufficiale si era risparmiata dallo sminuire l’azione di questo gruppo di separatisti veneti, giudicata ai limiti dell’anacronistico e del demenziale. Ma se sminuire mi è sempre sembrata l’unica reazione possibile di fronte a una storia così assurda e marginale, molto più delicato è avvicinarvisi senza pregiudizi e cercare di comprenderla.
È quello che fa Enrico Prevedello nel “suo romanzo verità”, così recita la bandella, Una rivolta – Orizzonti e confini del Nord-Est, pubblicato a settembre 2024 da nottetempo nella collana “Cronache”. Un libro scoperto per il richiamo di quel sottotitolo, Orizzonti e confini del Nord-Est, seppure respinta dalla copertina con raffigurato mezzo leone di San Marco: la stessa bandiera che, da quando ne ho ricordo vedo sventolare fuori da certe case, e da cui ho sempre ben mantenuto le distanze. Perché il león, in Veneto, è simbolo di incontestabile orgoglio, di identità – di mero campanilismo, di chiusura, insomma. La lettura di Prevedello spinge però a guardare oltre, dove non avevo guardato prima, e mostra l’altra metà del leone, una parte nascosta.
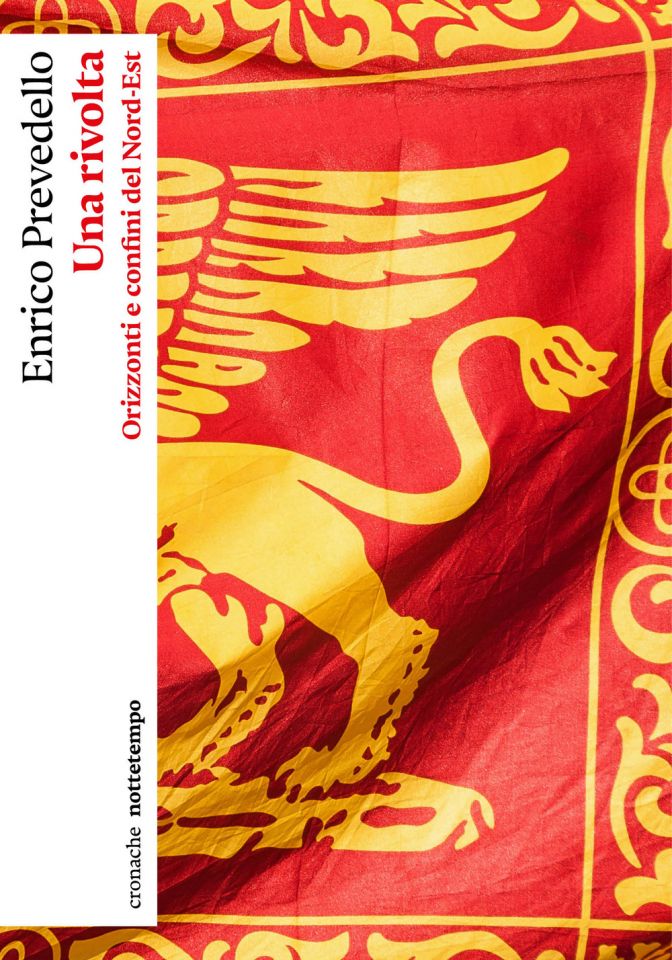 Sin dalle prime pagine, Una rivolta si presenta come un esperimento letterario che sorprende sia per l’ibridazione di genere e registro, sia per la sensibilità: se da una parte abbiamo un romanzo biografico, un reportage che racconta le vicende di Luciano Franceschi, piccolo imprenditore e indipendentista veneto sodale dei Serenissimi, nonché compaesano dell’autore e padre del suo amico d’infanzia Arturo, dall’altro abbiamo un memoir che delinea con affetto e malinconia i bordi di quel Veneto di campi e tralicci in cui Prevedello è cresciuto. A muoverlo nella scrittura è la più spontanea delle domande: perché. Perché un giorno Luciano, il papà di Arturo, ha preso una pistola e ha sparato a un banchiere? «Ecco, vedi, quella storia del venetismo l’ha fatto impazzire, è un invasato», pensa inizialmente Prevedello. Tuttavia, per trovare una risposta che si avvicini il più possibile alla verità, l’autore decide di addentrarsi nella storia personale di Luciano, il “Ciano”, e della sua famiglia, della moglie Emilia, la salernitana sempre sorridente con «la voce da sirena antiaerea», della madre Antonia, una sorta di Margaret Thatcher che rimprovera il figlio in dialetto veneto, e del fratello maggiore Enzo. L’autore racconta del suo rapporto con i Franceschi, proprietari dell’omonima bottega di alimentari in centro a Borgoricco, in provincia di Padova, di un piccolo caseificio e di un allevamento di maiali, e della sua amicizia con Arturo, con cui da bambino passa le giornate sulle rive dei fossi.
Sin dalle prime pagine, Una rivolta si presenta come un esperimento letterario che sorprende sia per l’ibridazione di genere e registro, sia per la sensibilità: se da una parte abbiamo un romanzo biografico, un reportage che racconta le vicende di Luciano Franceschi, piccolo imprenditore e indipendentista veneto sodale dei Serenissimi, nonché compaesano dell’autore e padre del suo amico d’infanzia Arturo, dall’altro abbiamo un memoir che delinea con affetto e malinconia i bordi di quel Veneto di campi e tralicci in cui Prevedello è cresciuto. A muoverlo nella scrittura è la più spontanea delle domande: perché. Perché un giorno Luciano, il papà di Arturo, ha preso una pistola e ha sparato a un banchiere? «Ecco, vedi, quella storia del venetismo l’ha fatto impazzire, è un invasato», pensa inizialmente Prevedello. Tuttavia, per trovare una risposta che si avvicini il più possibile alla verità, l’autore decide di addentrarsi nella storia personale di Luciano, il “Ciano”, e della sua famiglia, della moglie Emilia, la salernitana sempre sorridente con «la voce da sirena antiaerea», della madre Antonia, una sorta di Margaret Thatcher che rimprovera il figlio in dialetto veneto, e del fratello maggiore Enzo. L’autore racconta del suo rapporto con i Franceschi, proprietari dell’omonima bottega di alimentari in centro a Borgoricco, in provincia di Padova, di un piccolo caseificio e di un allevamento di maiali, e della sua amicizia con Arturo, con cui da bambino passa le giornate sulle rive dei fossi.
Una rivolta sorprende per l’ibridazione di genere e registro e per la sensibilità: da una parte romanzo biografico, un reportage, dall’altra un memoir
In questa ricerca di verità, diventa indispensabile per l’autore entrare nelle viscere del suo paese, Borgoricco, che è anche il paese di Giuseppe “Bepin” Segato, uno degli ideatori dell’attacco col Tanko in piazza San Marco del ’97. Intrecciando ricordi personali e aneddoti legati alla famiglia Franceschi e alla loro attività commerciale, la narrazione si sviluppa come un viaggio nel passato, che lambisce un’inchiesta sui movimenti autonomisti del Nord Italia. Prevedello si documenta sulle unioni padane, consulta gli statuti dell’autogoverno veneto e intervista più volte Luciano, le cui posizioni sono appunto simili a quelle del commando che nel ’97 aveva invaso piazza San Marco. Studia in questo modo il fenomeno delle leghe indipendentiste, che a partire dagli anni ’80 si erano imposte nelle regioni del Nord confluendo, come nel caso veneto, in un governo autodeterminato in guerra contro l’invasore italiano. Una narrazione assurda, ma che Prevedello cerca di comprendere e di riportare senza dare giudizi:
Ho capito allora Luciano, ho capito che cosa rendeva possibile il fatto che pur stando sullo stesso pavimento della bottega lui era in territorio veneto e io in quello italiano. Vivevamo in narrazioni diverse, versioni di mondo che non possono coesistere. Se c’è una versione di mondo ufficiale, più forte perché accettata e vissuta dalla maggioranza, è facile che questa cancelli l’altra: basta un’accusa di eresia, la carcerazione, un ricovero psichiatrico, a volte anche solo una risatina che riduce al ridicolo l’altro. Ma se chi vuole imporre una versione di mondo non dominante è determinato perché convinto che sia quella giusta, e se vuole che lo sia anche per gli altri, se quello è l’unico mondo in cui vorrebbe vivere e si trova davanti il nemico della propria realtà, allora può accadere che una pistola esca da un borsello, e chi ha potere sul territorio subisca la violenza di chi non lo ha.
In queste pagine non troviamo soltanto le pretese politiche, deliranti e inconcepibili, di un uomo e dei suoi compagni secessionisti, ma anche le sofferenze e le fobie di tutti quei piccoli e medi impresari del Nord Est che, proprio come Luciano, provavano sfiducia e rancore nei confronti dello Stato. Uno Stato che nulla avrebbe fatto per sostenerli e tutelare i loro sacrifici, ma che li avrebbe piuttosto isolati e deprivati.

Caffè Lavena in Piazza San Marco (1911-1912) di Italico Brass in cui sventola la bandiera del Regno d’Italia
C’è il «Veneto minore», per citare ancora Rumiz, una regione che ha conosciuto secoli di miseria e che si è poi improvvisamente arricchita, e di conseguenza smarrita, «scollegata dai suoi valori locali tradizionali»; una società che, travolta da un cambiamento troppo repentino e aggressivo, si è rifugiata nel falso mito dell’identità etnica, rappresentata simbolicamente dal leone di San Marco. L’adesione alle istanze ideologiche dei Serenissimi, il rifiuto dell’autorità dello Stato italiano, la rivendicazione di un autogoverno veneto che seguisse le proprie normative: quelle di Luciano Franceschi sono azioni estreme, sorte da un disagio sociale e tragicamente culminate nell’aggressione al direttore della banca di Campodarsego, che gli aveva negato un prestito per la sua impresa sull’orlo del fallimento. Un gesto disperato ma rivelatore, poiché l’intento di Luciano era anche quello di fermare la piaga di suicidi che stava ammorbando la classe degli imprenditori in Veneto, vittime della crisi economica del 2008, e tra i quali contava pure un suo caro amico, impresario edile.
Ecco, questa non è stata una crisi economica o il fallimento di un’azienda, è stato un fallimento di altro tipo, ma io non riesco più a fare differenza tra le relazioni, non mi importa più da dove partono e dove arrivano, ma solo di che tipo sono. Se fanno bene o se danno dolore. Borgoricco sta male, lo si vede dai fossi: l’autunno toglie ore di luce e a seconda della specie a cui appartieni resti verde, diventi arancione oppure ti si scoprono gli antociani e diventi rosso, fino a morire.
La storia di Luciano, all’inizio apparentemente lontana, sfocata, come le foto che lo ritraggono nel ’58 da bambino in braccio alla madre, finisce piano piano per sovrapporsi alla storia di Borgoricco, e anche a quella dell’autore. Il lirismo, la malinconia che la scrittura di Prevedello instilla nelle pagine del romanzo, raggiunge la massima espressione con il racconto della sua infanzia e adolescenza nella provincia veneta, di cui sa rendere con precisione l’atmosfera tiepida, velata – di quel profondo Veneto dal cielo limpido e il sole pallido, per dirla con le parole di Vasco Brondi.

Le bandiere del Regno Lombardo-Veneto sventolano in Piazza San Marco, Venezia (1850) di Carl Ludwig Rundt
Quello rappresentato è un luogo scorbutico, arido, a tratti grottesco: lo si può leggere nelle righe in cui Prevedello racconta della «putea del brasso», la “bambina del braccio”, fermata al centro estivo con un secco vien qua da due signori che volevano constatare che fosse proprio lei, con quella cicatrice, la bimba che aveva subito un grave incidente al braccio, strappato via giocando sul trattore del nonno. Lo si può leggere, ancora, nella testimonianza dei lavoretti estivi nei campi di tabacco, che l’autore descrive come un mondo veritiero e al tempo stesso tragicomico, in cui i personaggi ricordano un po’ tutti il Pojana, la caricatura incarnata dall’attore e drammaturgo veneto Andrea Pennacchi – emblema dei “padroncini”, avidi e xenofobi, quelli che danno lavoro, sì, ma in nero, quelli che i romeni è meglio se lavorano tra loro e non si mischiano «coi ’taliani». Sono piccoli aneddoti che fanno ridere controvoglia, per il loro umorismo brutale, e che ritraggono un posto in cui non si sente parlare d’altro se non di lavoro, fatica e schei – al più di ombre –, dove gli unici svaghi che un ragazzo possa contemplare sono le birrette con gli amici, le corse in Ciao lungo stradine di ghiaia mal illuminate, i videogiochi, la musica metal nei locali sperduti in mezzo ai campi. È questa, casa, per l’autore.
Vivere un territorio è lasciare un segno invisibile, una ics segnata nella rete di rapporti in cui sta sepolto un dono che si rievoca con empatia e condivisione. Tutto questo è invisibile, eppure lo sentiamo così forte da poter chiamare casa un solo luogo al mondo, quello in cui abbiamo tessuto le nostre reti, e dove possiamo tenere in vita una coincidenza che attraversa i corpi e il tempo col nostro stesso sguardo.
Nel suo vivere il territorio, Prevedello frequenta anche il carcere, il Due Palazzi di Padova, dove dapprima segue Luciano Franceschi nel periodo della sua detenzione per intervistarlo, anche a partire dalle pagine del suo diario, e dove viene convocato poi per una supplenza di due mesi come professore di lettere. Il racconto autobiografico di questa parentesi spaziotemporale consente all’autore di scoprire più da vicino l’istituzione penitenziaria, la sua natura e il suo funzionamento, e soprattutto i meccanismi malsani e violenti che ne pregiudicano le finalità.

Il carroarmato artigianale “Tanko” con la bandiera della Repubblica di Venezia durante l’assalto dei Serenissimi al campanile di San Marco il 9 maggio 1997
Anche in questo caso, l’esperienza personale di Prevedello, scevra di ogni pregiudizio, fa da prisma non soltanto a quella di Luciano, ma anche a quella degli altri detenuti: incontra uomini di cui ascolta le storie, le idee, le paure; gente per lo più rassegnata, senza prospettive, o in collera, che ha perso la fiducia e fatica a immaginarsi fuori dalla prigione. È proprio in questa testimonianza che Prevedello firma alcune delle pagine più appassionate del libro, in cui rimpiange di non aver tenuto una lezione su Pirandello, in particolare sulla sua novella Il treno ha fischiato.
Se vedeste la coda di un mostro vi farebbe terrore, sembrerebbe inconcepibile, ma se la riattaccaste al mostro sarebbe una normalissima coda di mostro. Allo stesso modo se riconducessimo l’azione di Belluca (arrivare in ritardo, non lavorare e reagire alla punizione del capo) alla sua vita quotidiana (lavorare anche di notte per sostenere una famiglia di tredici persone, di cui tre ciechi, sette marmocchi urlanti e due vedove che non fanno nulla in casa), capiremmo che è una reazione normalissima. Mi chiedo se il carcere non sia altro che un grappolo di gabbie in cui abbiamo infilato tante impossibili code di mostro.
Una rivolta è la cronaca di uno spaccato d’Italia, l’Italia dei bordi, della provincia più lontana. Con empatia e lucidità, Enrico Prevedello scava nel Veneto “dei capannoni coi tetti smontati”, al di là del cliché della regione che lavora e che produce; sospendendo qualsiasi tipo di giudizio, scava nelle sue contraddizioni, nelle inquietudini nascoste, e le riporta tutte in luce servendosi di una scrittura calibrata e poetica.
Mi chiedo se il carcere non sia altro che un grappolo di gabbie in cui abbiamo infilato tante impossibili code di mostro
«Anche le ombre che ci escono dalle teste per mettersi in un angolo a guardarci da fuori mentre dormiamo ci amano, come un padre che non riesce più a parlare»: il desiderio è comprendere non solo la storia di Luciano Franceschi, padre del suo amico d’infanzia Arturo, quella dei suoi affetti o quella dei suoi compagni venetisti, ma anche la propria, di storia, quella del luogo in cui è nato. Ed è una terra, quella narrata da Prevedello, che parla tanto di abbandono, solitudine, quanto di rabbia, malessere e morte. Una terra che va compresa oltre i suoi confini. È anche questa, casa.
In copertina Piazza San Marco (1898) di Maurice Brazil Prendergast
.jpg)
Commenta