Callisto I Papa
Banchieri di Dio
Nella Vita del Sommo Pontefice San Callisto I Papa, don Giovanni Bosco ci parla di un uomo specchiato. Prodigo di miracoli, Callisto I dispensa guarigioni e converte frotte di pagani. Con la sagacia del nibbio si districa in un tempo ancora incerto per i cristiani, il regno dell’imperatore Alessandro, ultimo della dinastia dei Severi; ma si posa con la grazia della colomba sui personaggi in cui s’imbatte, riuscendo a seminare nei loro cuori i virgulti del Vangelo. Intorno al 222 la sua opera di proselitismo si fa troppo prorompente e passa il segno: ad un cenno dell’imperatore, Callisto viene incarcerato e martirizzato. Il suo corpo è gettato in un pozzo mentre la sua anima ascende al Regno dei Cieli. I suoi successori e i fedeli seguaci di Cristo, illuminati dal suo santo esempio di difensore dell’ortodossia e campione della fede, lo ricorderanno soprattutto per le maestose catacombe che da lui prendono il nome. Questo, almeno, è ciò che Don Bosco ci fa sapere.
Ma non fu Severo Alessandro a decretare il martirio di Callisto, dato che egli era salito al trono, tredicenne, solo in quell’anno. I suoi tutori erano occupati in ben altre beghe che non nel sedare un pontefice iperattivo e troppe erano state le assurdità del predecessore, l’incredibile Eliogabalo, per cominciare il nuovo regno massacrando cristiani. Probabilmente Callisto trovò la morte durante una sollevazione popolare. Don Bosco sbagliò per l’inevitabile pressappochismo storico di chi studiava su martirologi e storie ecclesiastiche, o volle glissare su dati che non hanno senso – quando non fanno danno – nell’economia di un’agiografia. In particolare non si servì, o non poté servirsi, di documenti che rendono in tinte ben diverse la figura di Callisto I. Sono le parole di un antipapa, Ippolito di Roma, che a Callisto si oppose con cieca e lunga determinazione.
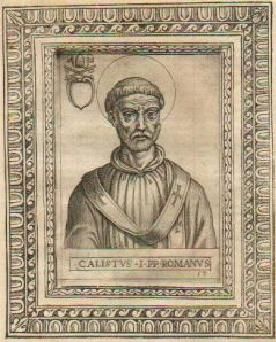 Il cristianesimo era una religione giovane, priva di capi ma ricca di teste. La fragilità della Chiesa d’allora lasciava che chiunque avesse un minimo d’idee, d’eloquenza e d’autorità potesse dire la sua sulla natura del Cristo, di cui non era neppure chiaro da che parte venisse, se dall’indice di Dio o dal ventre di Maria (né se da qualche parte effettivamente venisse). Questa singolare libertà d’espressione generava una quantità innominabile di sette più o meno eterodosse il cui spettacolo, ai nostri occhi profani, è spesso motivo di confusione. La gerarchia di un’istituzione non ancora riconosciuta dalla legge non aveva speranze di emendare se stessa in modo efficace e tantomeno il vescovo di Roma aveva modo di dare concreto seguito al suo giudizio, quando condannava chicchessia per le sue idee in materia di fede. Alle scomuniche si rispondeva facilmente con gli scismi e le eresie fioccavano. È proprio nel seno di questo continuo e mutevole dibattito teologico e politico che s’inserisce la rancorosa descrizione che Ippolito ci fa di Callisto papa e uomo. Della sua opera in greco Refutatio omnium haeresium, meglio conosciuta come Philosophumena, il brillante Ippolito dedica un ampio capitolo del libro IX ad una filippica contro Callisto. Seguendo lo spirito dell’opera, attenta e capillare inquisizione di ogni eresia e superstizione presente e passata, Ippolito si scaglia contro dottrina teologica e politica penitenziale di questo papa indegno: oltre ad avallare e condividere l’eresia di Noeto (il cosiddetto monarchianismo modale) e tutti i suoi derivati, questo Callisto è lassista contro adulterio e fornicazione, favorevole al matrimonio del clero, nonché doppio, subdolo e manipolatore. Per rincarare la dose, dice Ippolito, quel papa Zefirino che lo designò suo successore era un asino ignorante, un avido imbecille. Ma per completare il quadro completamente negativo di un uomo che avversò fino allo scisma e che continuò ad odiare anche da morto, Ippolito riesuma da sotto la dignità papale la gioventù di Callisto. Il candido ritratto dipinto da Don Bosco, già qui sfregiato dalla dura critica dottrinale di Ippolito, trova adesso la sua ferita maggiore.
Il cristianesimo era una religione giovane, priva di capi ma ricca di teste. La fragilità della Chiesa d’allora lasciava che chiunque avesse un minimo d’idee, d’eloquenza e d’autorità potesse dire la sua sulla natura del Cristo, di cui non era neppure chiaro da che parte venisse, se dall’indice di Dio o dal ventre di Maria (né se da qualche parte effettivamente venisse). Questa singolare libertà d’espressione generava una quantità innominabile di sette più o meno eterodosse il cui spettacolo, ai nostri occhi profani, è spesso motivo di confusione. La gerarchia di un’istituzione non ancora riconosciuta dalla legge non aveva speranze di emendare se stessa in modo efficace e tantomeno il vescovo di Roma aveva modo di dare concreto seguito al suo giudizio, quando condannava chicchessia per le sue idee in materia di fede. Alle scomuniche si rispondeva facilmente con gli scismi e le eresie fioccavano. È proprio nel seno di questo continuo e mutevole dibattito teologico e politico che s’inserisce la rancorosa descrizione che Ippolito ci fa di Callisto papa e uomo. Della sua opera in greco Refutatio omnium haeresium, meglio conosciuta come Philosophumena, il brillante Ippolito dedica un ampio capitolo del libro IX ad una filippica contro Callisto. Seguendo lo spirito dell’opera, attenta e capillare inquisizione di ogni eresia e superstizione presente e passata, Ippolito si scaglia contro dottrina teologica e politica penitenziale di questo papa indegno: oltre ad avallare e condividere l’eresia di Noeto (il cosiddetto monarchianismo modale) e tutti i suoi derivati, questo Callisto è lassista contro adulterio e fornicazione, favorevole al matrimonio del clero, nonché doppio, subdolo e manipolatore. Per rincarare la dose, dice Ippolito, quel papa Zefirino che lo designò suo successore era un asino ignorante, un avido imbecille. Ma per completare il quadro completamente negativo di un uomo che avversò fino allo scisma e che continuò ad odiare anche da morto, Ippolito riesuma da sotto la dignità papale la gioventù di Callisto. Il candido ritratto dipinto da Don Bosco, già qui sfregiato dalla dura critica dottrinale di Ippolito, trova adesso la sua ferita maggiore.
Al volgere del secondo secolo della nostra era, quando il figlio degenere di Marco Aurelio, Commodo, dava scandalo all’impero combattendo nell’arena, Callisto era uno degli schiavi di Carpoforo, famiglio dell’imperatore e seguace di Cristo. Secondo una consuetudine ben radicata negli usi del tempo, il ricco Carpoforo aveva concesso al suo schiavo una grossa somma di denaro da investire. Con questo cospicuo peculium Callisto avviò una banca di deposito e prestito, nel rione della Piscina Pubblica, sotto l’Aventino; volle dedicare i suoi servizi alle vedove e agli orfani e, naturalmente, a tutti i confratelli cristiani. I clienti accorrevano a versare il loro denaro nelle sue mani, rassicurati dal vigile Carpoforo, il cui nome era una garanzia. Ma ben presto, non è ben chiaro come,  Callisto dilapidò il patrimonio ricevuto e perse anche il denaro dei depositi. Quando subodorò che qualcuno aveva spifferato a Carpoforo quanto male gli andassero gli affari, spaventato dall’ira del padrone che in lui aveva riposto fiducia e fama, Callisto si fece uccel di bosco. Fuggì fino a Porto, presso Ostia, e s’imbarcò sulla prima nave in partenza: sarebbe andato dovunque fosse diretta, pur di sfuggire alle grinfie dei creditori e del padrone. Ma Carpoforo, messo in guardia da quanto sapeva, gli aveva dato la caccia, indovinandone la meta. L’imbarcazione scelta dallo schiavo come estremo rifugio era ancorata in mezzo alla rada, e il suo nocchiere manovrava senza fretta; Callisto distinse chiaramente Carpoforo che si sbracciava sul molo e, sentendosi braccato, decise per il suicidio. Si diede al mare senza pensarci due volte, ma i marinai, messi in allarme da Carpoforo, si calarono in acqua e arpionarono il tentato suicida, così restituito al padrone. Questi lo spedì alle macine, ma ben presto si lasciò convincere a rilasciare Callisto. I creditori, convinti che lo schiavo avesse ancora i loro soldi, avevano interceduto per lui; ma sarebbero rimasti con un palmo di naso, perché Callisto era completamente al verde.
Callisto dilapidò il patrimonio ricevuto e perse anche il denaro dei depositi. Quando subodorò che qualcuno aveva spifferato a Carpoforo quanto male gli andassero gli affari, spaventato dall’ira del padrone che in lui aveva riposto fiducia e fama, Callisto si fece uccel di bosco. Fuggì fino a Porto, presso Ostia, e s’imbarcò sulla prima nave in partenza: sarebbe andato dovunque fosse diretta, pur di sfuggire alle grinfie dei creditori e del padrone. Ma Carpoforo, messo in guardia da quanto sapeva, gli aveva dato la caccia, indovinandone la meta. L’imbarcazione scelta dallo schiavo come estremo rifugio era ancorata in mezzo alla rada, e il suo nocchiere manovrava senza fretta; Callisto distinse chiaramente Carpoforo che si sbracciava sul molo e, sentendosi braccato, decise per il suicidio. Si diede al mare senza pensarci due volte, ma i marinai, messi in allarme da Carpoforo, si calarono in acqua e arpionarono il tentato suicida, così restituito al padrone. Questi lo spedì alle macine, ma ben presto si lasciò convincere a rilasciare Callisto. I creditori, convinti che lo schiavo avesse ancora i loro soldi, avevano interceduto per lui; ma sarebbero rimasti con un palmo di naso, perché Callisto era completamente al verde.
Ben sapendo di essere spacciato, il futuro papa cercò di nuovo la morte, stavolta con un’azione a dir poco spettacolare. Aspettò il sabato successivo, entrò in una sinagoga e cominciò a insultare pesantemente gli ebrei, disturbando le sacrosante letture talmudiche. I giudei lo fecero nero come un fico di Cartagine e lo trascinarono davanti al prefetto urbano, Fusciano. Quell’odioso Callisto, dicevano gli ebrei, aveva violato il loro diritto di culto, interrompendo i loro riti, perché cristiano. Carpoforo, di nuovo messo sul chi vive dai rapidi rumores dell’Urbe, si era precipitato ai ginocchi di Fusciano, implorandolo di non ascoltare i perfidi giudei. Callisto non era un cristiano, ma semplicemente un bancarottaro fraudolento, che cercava di non pagare i suoi debiti nella maniera più infida, morendo. Convinto più dalla rabbia degli ebrei che dalle ambigue parole di Carpoforo, che forse faceva i suoi interessi di padrone, Fusciano spedì Callisto nelle miniere di Sardegna, ad metalla. Con la condanna, Carpoforo aveva perso ogni diritto su di lui. Prigioniero dei lavori forzati, ora Callisto era un uomo libero. Ma la Sardegna non l’avrebbe visto a lungo. Presto il presbitero Giacinto avrebbe condotto là una spedizione salvifica per conto dell’amante di Commodo, la cristiana e dissoluta Marcia. La donna aveva chiesto al pontefice di allora, Vittore, di redigere una lista di cristiani da prelevare e restituire alla libertà; approfittando dell’eccezionale evento, Callisto riuscì a farsi passare per cristiano, o quantomeno a convincere Giacinto a salvarlo, nonostante Vittore avesse consapevolmente escluso il suo nome dalla lista. Vittore non fu contento dell’astuzia sfacciata di Callisto ma, uomo compassionevole, decise di dargli una pensione e di collocarlo ad Anzio. Morto Vittore, il suo successore, Zefirino – l’imbecille – richiamò Callisto e gli assegnò la gestione di quel che nell’opinione dell’uomo che lo riscoprì, Giovan Battista de Rossi, era il principale e più famoso cimitero della comunità paleocristiana di Roma, le catacombe presso la porta Appia – dette appunto di San Callisto. Il malandrino avrebbe poi scalato la gerarchia della Chiesa, certo facendo uso delle sue arti melliflue, fino al soglio pontificio. Questa è l’avvelenata versione dell’antipapa Ippolito.
Dal dibattito che sorse alla metà del XIX secolo sulla paternità del Philosophoumena emerse, nel 1853, la vincente opinione di Ignaz von Dollinger, eminente teologo e storico tedesco, che l’attribuiva appunto ad Ippolito, anche contro il parere del de Rossi, che lo voleva di Tertulliano, e di chi ne aveva curato la prima edizione critica, uscita dalle stampe di Oxford nel 1851. Il lavorio sul testo di Ippolito, inizialmente attribuito ad Origene, permise di discernere la realtà dei fatti, dietro il velo di astio steso dall’antipapa. Con ogni probabilità, Callisto non aveva perso il denaro per sua colpa, non tentò di suicidarsi né con l’acqua né con gli ebrei (da cui anzi forse doveva riscuotere dei debiti), non si finse mai cristiano ma sempre lo fu sinceramente e non poté non avere doti significative se, tra i molti altri dotti seguaci, Zefirino lo scelse come suo successore. Inoltre, aldilà dello scontro dottrinario, è possibile che i dissapori tra Callisto e Ippolito nascessero principalmente dal fatto che essi erano i capi romani di due comunità cristiane differenti per lingua, Callisto di quella latina e Ippolito di quella greca.
Ippolito non era in difetto di testi che predicassero contro l’usura. Senza azzardare un contatto decisivo con Aristotele, che la stigmatizza nell’Etica Nicomachea, già il Vangelo secondo Luca si esprime negativamente su di essa; colpisce e fa riflettere sulla mutabilità, nel tempo, della percezione morale delle attività umane da parte dell’uomo stesso – di quanto il giusto sia una categoria costruita culturalmente – il fatto che agli occhi di Ippolito, Callisto era un uomo malvagio perché falso, ipocrita, intrigante, dissimulatore ed eretico, perché l’accusava a sua volta di eresia, perché aveva il cuore riempito di veleno. Perché aveva perso tutto il denaro suo ed altrui, perché aveva tentato il suicidio per futili motivi e perché si era salvato con l’inganno. Ma non perché era stato banchiere, quando un banchiere era sempre anche un usuraio.
Parte della serie Banchieri di Dio
Galleria




Commenta