Non tutte le canzoni di Natale fanno schifo
Le canzoni per chi non sopporta il periodo più magico e melenso dell’anno
Ogni anno in questo periodo si avverte qualcosa di speciale che aleggia nell’aria. Spuntano abeti nelle piazze, le strade si illuminano di ghirlande e angioletti, la pubblicità inonda la cassetta della posta e gli occhi dei bambini sono pieni di meraviglia. Dai negozi arrivano canzoni che parlano di angeli in apprensione, notti silenziose e caldarroste fatte sul fuoco. E, nonostante abbia varcato la soglia dei cinquanta già da un po’, qualcosa dentro di me ribolle di una furia adolescenziale e vorrei solo tapparmi le orecchie.
Odiare è una parola forte. La parola odiare dovrebbe essere riservata alle forze più distruttive e implacabili nelle nostre vite: razzismo, sessismo, ingiustizie. E ovviamente al Ringraziamento, la festa più ipocrita e al contempo quella meno sensuale, un giorno in cui viene celebrato il furto delle terre dei nativi americani e i colonizzatori inglesi possono finalmente festeggiare la dipartita di questi cittadini non graditi. Credo che ci debba essere una ragione se sono state scritte così poche canzoni per il Ringraziamento e se ce ne sono ancora meno di belle.
Il Natale non ispira lo stesso livello di repulsione della salsa di mirtilli o dei cappelli con la fibbia. Ma la sua ubiquità, il suo pietismo, il consumismo, l’allegra e gioviale insistenza secondo cui ci dovremmo sentire tutti allo stesso modo nello stesso momento possono dare la nauseante sensazione di essere bullizzati dagli elfi. La solitudine, l’alienazione e l’ambiguità non sono permesse, o per lo meno non si possono lasciar trapelare. Ogni senso di colpa e di frustrazione è represso. E non esiste un posto in cui questa tirannia elfica sia più prominente delle insopportabili canzoncine natalizie.
In politica si dice che il patriottismo è l’ultimo rifugio della canaglia, nella cultura pop è l’album di Natale
Ciò non significa che tutte queste canzoni siano nate come dei veri e propri abomini. Non ho alcun dubbio che quando Bing Crosby ha fatto sentire per la prima volta a un pubblico ansioso White Christmas di Irving Berlin, giusto poche settimane dopo Pearl Harbor, le persone presenti si siano veramente emozionate. E Nat King Cole è stato un grandissimo musicista jazz, quindi posso provare a perdonargli Chestnuts roasting on an open fire. Ma se non sentirò mai più Winter Wonderland, Silver Bells o It’s the Most Wonderful Time of the Year morirò felice. E no, non me ne frega niente se sono cantate da Annie Lennox, Justin Bieber o Gwen Stefani. In politica si dice che il patriottismo è l’ultimo rifugio della canaglia, nella cultura pop è l’album di Natale.
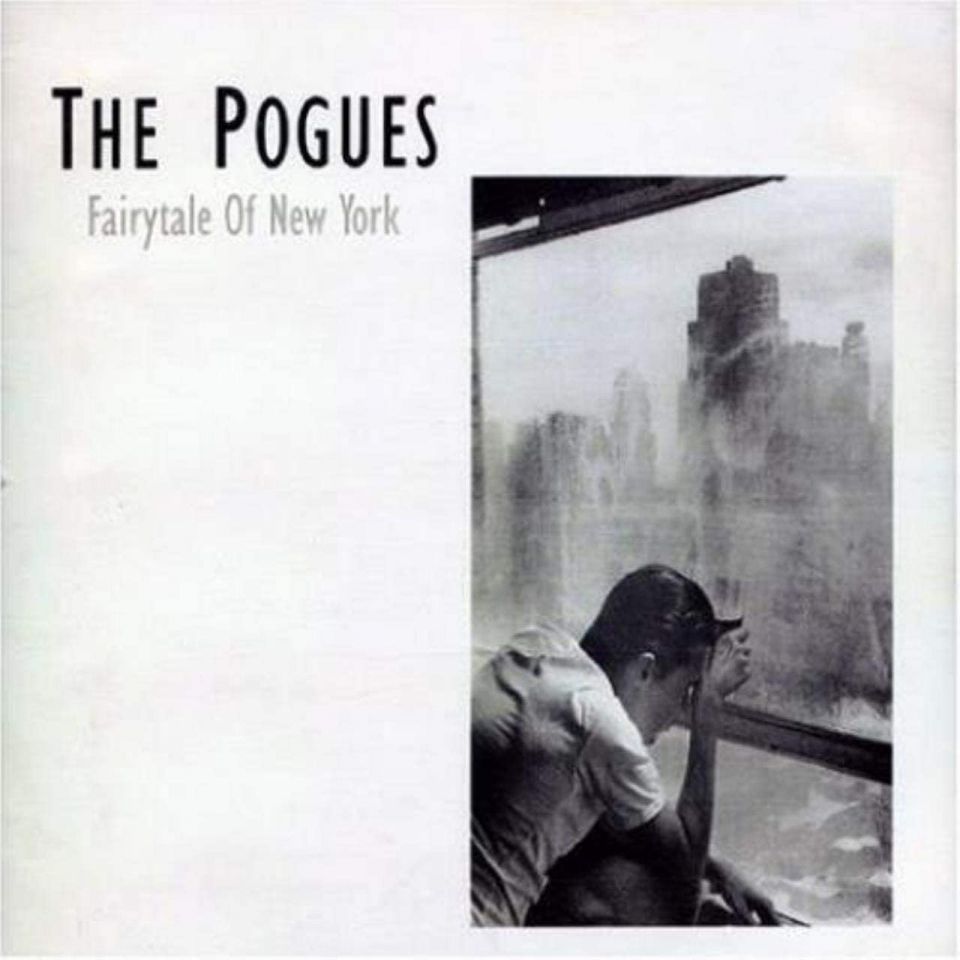 Comprare i regali per le persone care a dicembre è una tortura. È impossibile attraversare Herald Square senza essere bombardati da Deck the Halls e Sleigh the Ride. Così ogni anno trovo conforto e consolazione in alcune bellissime canzoni che sono state scritte in fiera opposizione allo spirito natalizio.
Comprare i regali per le persone care a dicembre è una tortura. È impossibile attraversare Herald Square senza essere bombardati da Deck the Halls e Sleigh the Ride. Così ogni anno trovo conforto e consolazione in alcune bellissime canzoni che sono state scritte in fiera opposizione allo spirito natalizio.
Purtroppo, uno fra i più belli di questi inni è sul punto di venire inglobato nello stantio repertorio tradizionale. Questo potrebbe essere l’ultimo anno in cui si può ascoltare Fairytale of New York dei Pogues con il calice alzato e un’aria di sfida. Nell’improbabile caso in cui ancora non l’abbiate sentita (il Daily Mail l’ha recentemente nominata la canzone di Natale preferita nel Regno Unito) è una canzone che narra in modo cinematografico la storia di un uomo che smaltisce la sbronza della vigilia di Natale in cella, ricordando la vita che avrebbe potuto avere. Cinque anni fa Joyce Wadler, una giornalista del New York Times, ha scalfito la reputazione della canzone in una rubrica umoristica. Ridicolizzava la canzone in quanto inviterebbe «a una malinconia e un compatimento quasi decadenti, che ti avvolgono con i loro vapori come incensi preziosi». Ben più dannose, invece, sono state le varie cover, una più stucchevole dell’altra, cantate da amanti del virtuosismo che hanno trasformato la canzone in una sorta di colonna sonora Disney.
A volte una canzone diventa un classico semplicemente perché lo merita
Ma torniamo alla versione originale, che ora ha più di trent’anni. È la quarta traccia dell’album If I Should Fall From Grace With God ed è preceduta da tre potenti brani celtic punk. Provate ad ascoltare l’attacco di pianoforte alla C’era una volta in America come se non lo aveste mai sentito. Fate finta di non esservi assuefatti alla voce graffiante di Shane MacGowan e alle parole rozze che ha scritto per contrastare l’atmosfera malinconica e marinaresca della melodia realizzata da Jem Finer. E, soprattutto, fate attenzione a come il pezzo cambia totalmente quando entra con prepotenza la voce di Kristy MacColl, nei panni di quella «vecchia puttana tossica» che descrive McGowan ma che a differenza sua è alle prese solo con le canne delle cornamuse mentre inizia a ricoprire il suo compagno di pesanti insulti e maledice tutte le bugie che le ha rifilato. «Nell’opera, se si sta parlando di duetti operistici, è quello che fa la donna che è davvero importante» ha detto più tardi McGowan. «L’uomo mente, la donna dice la verità». Dopo aver sentito la sua performance, McGowan ha deciso di tornare di nuovo in sala registrazione e rifare la sua parte per intonarsi meglio alla meravigliosa alchimia di vizio e grazia che Kristy MacColl era riuscita a mettere insieme. Se riuscite a grattare via la patina di kitsch che col tempo si è accumulata su questa canzone e ad ascoltarla come se fosse la prima volta, vi farà venire il nodo alla gola. E non perché diversi anni dopo MacColl, nel tentativo di salvare suo figlio, è stata travolta da un’imbarcazione che l’ha uccisa. A volte una canzone diventa un classico semplicemente perché lo merita.
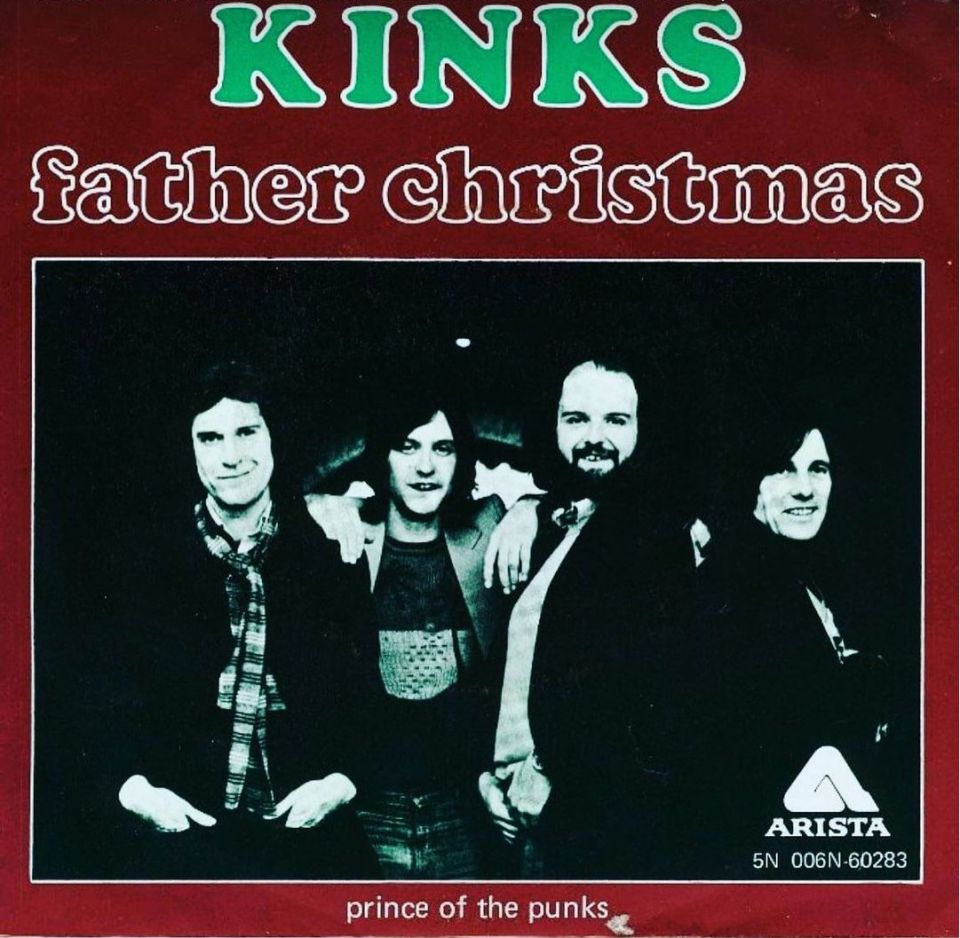 Un po’ meno raffinata, ma altrettanto duratura, è Father Christmas dei Kinks: un irriverente pugno in faccia allo spirito natalizio. Se si ascoltasse distrattamente Fairytale of New York si potrebbe cadere nell’errore di pensare che sia una canzonetta dolce e allegra. Sarebbe difficile commettere lo stesso errore con Ray Davies che canta di un gruppo di teppisti intenti a scippare un Babbo Natale in costume («Babbo Natale dacci i soldi!») e il suo fratellino che squarcia a colpi di chitarra elettrica il motivetto di campanellini iniziale in un'estasi omicida. C’è un motivo per cui i Kinks non sono mai diventati delle star: semplicemente non avrebbero mai fatto quello che gli si diceva di fare. Non li avremmo mai sentiti implorare di poter tornare a casa per il bianco Natale o languire aspettando la persona amata sotto il vischio. Avrebbero insistito nel trovare qualche prospettiva perversa che li avrebbe sistematicamente buttati fuori dalla musica mainstream. Così perversa che in effetti Ray Davies, un inglese fatto e finito, ha scritto una tra le pochissime canzoni ascoltabili sul Ringraziamento.
Un po’ meno raffinata, ma altrettanto duratura, è Father Christmas dei Kinks: un irriverente pugno in faccia allo spirito natalizio. Se si ascoltasse distrattamente Fairytale of New York si potrebbe cadere nell’errore di pensare che sia una canzonetta dolce e allegra. Sarebbe difficile commettere lo stesso errore con Ray Davies che canta di un gruppo di teppisti intenti a scippare un Babbo Natale in costume («Babbo Natale dacci i soldi!») e il suo fratellino che squarcia a colpi di chitarra elettrica il motivetto di campanellini iniziale in un'estasi omicida. C’è un motivo per cui i Kinks non sono mai diventati delle star: semplicemente non avrebbero mai fatto quello che gli si diceva di fare. Non li avremmo mai sentiti implorare di poter tornare a casa per il bianco Natale o languire aspettando la persona amata sotto il vischio. Avrebbero insistito nel trovare qualche prospettiva perversa che li avrebbe sistematicamente buttati fuori dalla musica mainstream. Così perversa che in effetti Ray Davies, un inglese fatto e finito, ha scritto una tra le pochissime canzoni ascoltabili sul Ringraziamento.
In quanto fiera dichiarazione di intenti, Father Christmas è difficile da battere. Si fa beffe dell’ascoltatore, gli sfila i soldi di tasca e lo sfida a non cantarla
Ovviamente ha anche scritto decine di canzoni bellissime, più sottili e complicate, come ad esempio Waterloo Sunset, Days, Sunny Afternoon e Lola. Ma in quanto fiera dichiarazione di intenti, Father Christmas è difficile da battere. Si fa beffe dell’ascoltatore, gli sfila i soldi di tasca e lo sfida a non cantarla. Fa finta di prendere una svolta sentimentale verso la fine, ma poi rimane fedele a sé stessa e fa un gran casino. E ogni Natale è lì a ricordarmi che se non avessi avuto Davies come modello quando ero più giovane, forse avrei passato più tempo a cercare di essere «normale» e integrarmi. E sarebbe stato un vero peccato, almeno per chi, come me, voleva diventare uno scrittore.
 C’è un’altra canzone che si annovera nel genere guerra al Natale di cui volevo parlarvi, e scommetto che non l’avete mai sentita, se non altro perché fa finta di non essere una canzone sul Natale. Thank God It’s Not Christmas è una canzone caduta nell’oblio suonata da un gruppo, gli Sparks, anch’esso caduto nell’oblio (almeno negli Stati Uniti). Come i Kinks, erano due fratelli ma, a differenza dei Davies, Ron e Russel Mael sono ebrei statunitensi originari dell’assolata Los Angeles che, nel mezzo dell’ondata glam-rock degli anni ‘70, si sono trasferiti nella fredda Inghilterra. La canzone porta i segni caratteristici del suo tempo: falsetto, tastiere volutamente insignificanti e una produzione musicale che raderebbe al suolo un rifugio antiaereo. Sembra una cosuccia che hanno ficcato alla fine del lato A dell’album Kimono My House. Ai tempi non è neanche uscito come singolo. Infatti, non ci ho pensato per anni finché un giorno mi sono ritrovato a Londra una vigilia di Natale e ho capito di cosa parlava la canzone.
C’è un’altra canzone che si annovera nel genere guerra al Natale di cui volevo parlarvi, e scommetto che non l’avete mai sentita, se non altro perché fa finta di non essere una canzone sul Natale. Thank God It’s Not Christmas è una canzone caduta nell’oblio suonata da un gruppo, gli Sparks, anch’esso caduto nell’oblio (almeno negli Stati Uniti). Come i Kinks, erano due fratelli ma, a differenza dei Davies, Ron e Russel Mael sono ebrei statunitensi originari dell’assolata Los Angeles che, nel mezzo dell’ondata glam-rock degli anni ‘70, si sono trasferiti nella fredda Inghilterra. La canzone porta i segni caratteristici del suo tempo: falsetto, tastiere volutamente insignificanti e una produzione musicale che raderebbe al suolo un rifugio antiaereo. Sembra una cosuccia che hanno ficcato alla fine del lato A dell’album Kimono My House. Ai tempi non è neanche uscito come singolo. Infatti, non ci ho pensato per anni finché un giorno mi sono ritrovato a Londra una vigilia di Natale e ho capito di cosa parlava la canzone.
Per qualcuno nato e cresciuto a Manhattan è uno shock vedere una delle più grandi città al mondo spegnersi completamente. Un quartiere dopo l’altro di case grigie e silenziose, senza nemmeno una lucina che trapela dalle finestre, e le strade completamente deserte. Niente ristoranti cinesi, pub o cinema in cui rifugiarsi. Nemmeno il bagliore della TV alle finestre con le immagini di qualche classico Disney. Anche la metropolitana è chiusa. All’improvviso ho compreso la profonda disperazione di Mael quando cantava che per quanto deludenti e dissolute le altre 364 notti potessero essere, nessuna era peggio della notte di Natale «quando ci sei solo tu e nulla da fare».
Grazie a Dio, qualcuno ha scritto qualche canzone per rendere questi giorni un pochino più onesti e forse un po’ meno cupi
Per alcune persone potrebbe essere il periodo più bello dell’anno ma per altri è il periodo in cui si inizia a bere e a drogarsi pesantemente, oppure è quel periodo in cui bisogna comprare nuovi lucchetti per l’armadietto delle pistole perché i parenti vengono a casa, o di tirare giù la copia di Manuale per aspiranti suicidi dal ripiano alto della libreria. Perché la distanza fra quello che la società dice che si dovrebbe provare e quello che si prova davvero diventa insopportabile. «Ci sarà permesso di sentirci controcorrente?» cantava Mael. E ovviamente la risposta è un roboante no. Le persone perse e sole sono relegate ai margini delle festività, lasciate fuori a guardare le vetrine decorate, col naso schiacciato sul vetro. Oppure soffocate dall’ennesima versione di Jingle Bell Rock. Grazie a Dio, qualcuno ha scritto qualche canzone per rendere questi giorni un pochino più onesti e forse un po’ meno cupi.
E grazie a Dio, quella vigilia di Natale a Londra non ero da solo. Ero con mia moglie e i miei due figli, che mi hanno perdonato per averli fatti girare a vuoto, convinto che ci fosse un posto aperto per mangiare. Abbiamo camminato per ore senza vedere anima viva o anche solo una decorazione appesa. Alla fine abbiamo visto una luce tremolante all’angolo della strada. Un discount era ancora aperto. Siamo entrati e abbiamo trovato un ragazzo pakistano dietro al bancone, mentre le note ammiccanti di Last Christmas degli Wham! uscivano dallo stereo. Anni dopo, il cantante e compositore George Michael sarebbe stato trovato morto all’età di 53 anni una mattina di Natale, dopo una vita di tormenti solo leggermente accennati nella sua musica. Ma quella notte non stavo pensando a lui o alla sua canzone. Stavo pensando a quanto ero grato che fossero rimasti abbastanza sandwich al prosciutto e formaggio nel frigo da poter sfamare la mia famiglia. Abbiamo pagato, ringraziato il commesso per la sua presenza e ci siamo incamminati nella notte gelida mentre la porta si richiudeva tintinnando alle nostre spalle.
Peter Blauner è uno scrittore, sceneggiatore e giornalista statunitense, vincitore del Premio Egar per il suo romanzo Il nero dell’arcobaleno. Si è occupato di cronaca nera e politica per la rivista New York e ha scritto per diverse serie tv fra cui Law & Order e Blue Bloods. Questo articolo è stato pubblicato su Literary Hub l’11/12/2017 ► Why I Hate Christmas (But Love Songs About Hating Christmas) | Traduzione di Erica Francia

Commenta