Il complotto del lavoro
Illusioni e delusioni di una generazione nella fantascienza del lavoro contemporaneo dal romanzo Nero di Giommoni
Il dio del lavoro occupa tutto il tempo a disposizione delle nostre vite: sia quando c’è che quando non c’è, con la sua assenza pesante, esige un tributo di energie e dedizione totale al suo culto. Cercare lavoro è un lavoro a sua volta, sicché sembra impossibile sottrarsi alla tirannia di questo circolo vizioso; immaginarsi una vita diversa, libera dal ricatto dell’occupazione e della disoccupazione, ha il sapore dell’eresia. Luca Giommoni nel suo Nero. Il complotto dei complotti (effequ, 2024) cerca di immaginare la più surreale delle vie d’uscita dalla disoccupazione, attraverso un improbabile viaggio nello spaziotempo. In questa satira fantascientifica della nostra epoca, a metà tra Vonnegut e Fantozzi, si muovono illusioni, delusioni, nevrosi di una generazione, quella dei trentenni, intrappolata tra un vecchio mondo pieno di promesse non mantenute e la nuova realtà del lavoro, fondata sul precariato e sul rinvio costante del momento in cui l’esistenza si stabilizzerà in qualche forma definitiva. A fare da sottofondo, l’implacabile ideologia del merito, che rende ogni fallimento una colpa, espiabile solo attraverso la ricerca incessante di nuove opportunità lavorative. Più facile a dirsi che a farsi, perché a ogni colloquio di lavoro i requisiti per l’assunzione diventano più surreali.
«Le faccio davvero i miei complimenti, dottor Ceccobelli, le sue soft skills, i titoli di studio, il livello Ci due dell’inglese, anche i risultati del test attitudinale risultano perfettamente in linea con il profilo richiesto a eccezione, purtroppo, di un piccolo particolare».
«Quale piccolo particolare?»
«Lei non ha il diabete, dottor Ceccobelli».
«Non era richiesto tra i requisiti nell’annuncio».
«Il diabete non si richiede, si ha».
«E se non fossi cosciente della mia condizione diabetica?»
«Non migliorerebbe la sua posizione, dottor Ceccobelli. Sarei tenuta a riportare il fatto e, sia che abbia dichiarato il falso nell’autodichiarazione o semplicemente ignori la sua condizione diabetica, non sarebbe di certo un bel biglietto da visita con cui presentarsi al secondo colloquio con il direttore del Personale: una persona che non ha coscienza neanche delle proprie condizioni di salute come potrebbe prendersi cura degli interessi dell’azienda?».
«C’è un secondo colloquio?»
«No».
«Ci sarebbe se avessi il diabete? Me lo posso far venire».
Nel mondo del lavoro contemporaneo, non contano le inclinazioni personali: l’importante è sacrificarsi sull’altare della flessibilità. Così il disoccupato Nero Ceccobelli e il suo migliore amico Alfredo Ferri, alle prese con la caccia all’impiego nella cittadina immaginaria di Carolì, passano di colloquio in colloquio, con il disincanto di chi ha capito le regole del gioco ma non è in grado di cambiarle: «flessibilità, se ti chiamavi Steve Jobs, era poter scegliere di fare un certo lavoro tra diversi proposti; se ti chiamavi Alfredo Ferri significava dover fare in un certo momento l’unico lavoro proposto». Nero, anche se è consapevole del suo destino, non riesce a smettere di inseguire una chimera che non afferra mai, quella del posto fisso. Con la stessa carica di superstizione con cui si compra un biglietto della lotteria, Nero stacca il prossimo numerino al centro per l’impiego e attende il suo turno, come suggerisce la grafica del romanzo, in cui i paragrafi sono suddivisi proprio attraverso il classico scontrino che si ottiene nelle liste di attesa degli sportelli pubblici. Nel frattempo, la sua vita, come quella di tutti, va a rotoli, precipitando, analogamente alla figura dell’immagine di copertina, nel cono di luce di una lampada d’ufficio.
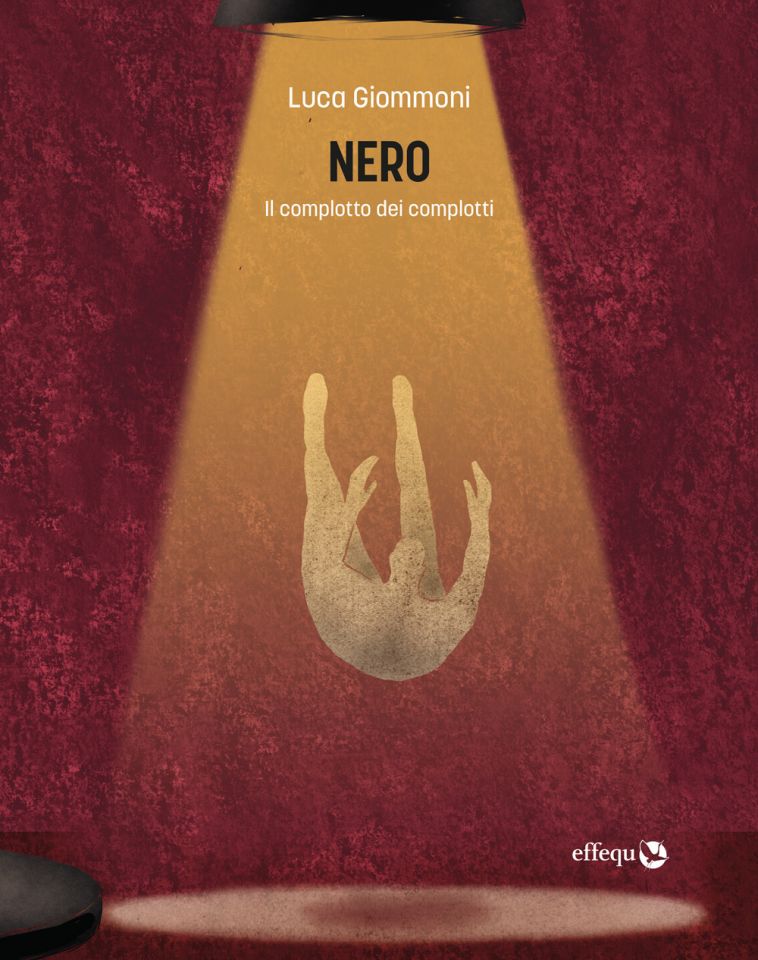 Accadeva questo, Accadrà questo, Accade questo: la scansione del romanzo in tre parti cronologicamente non consecutive confonde i piani temporali e aggroviglia la trama in un labirinto inestricabile, simile alla ricerca inconcludente di un lavoro da parte di Nero. Il presente viene continuamente rimandato, fino alla fine del libro. Intrappolato tra i ‘se’ e i ‘ma’ della sua impotenza, Nero trova sollievo soltanto nelle teorie del complotto, per cercare di dare un senso alla sua assurda condizione: «In realtà è già tutto molto più spaventoso di così, più difficile da accettare: i complotti ci rendono solo più comprensibile ciò che non è comprensibile». Peraltro, il nome stesso di Nero è stato scelto dalla madre per contrastare un presunto complotto per diffondere impunemente il nome Bianca, nato nei mesi successivi all’uscita dell’omonimo film di Nanni Moretti. Secondo la logica del complotto, se le cose vanno male, deve essere colpa di qualcuno, che così ha voluto. Gli imputati più ovvi per spiegare il disastro in cui i trentenni si trovano sono i genitori, appartenenti alla generazione dei boomer, che non capiscono o non vogliono vedere che cosa il mondo è diventato, ma che hanno sicuramente la loro parte di torto: sono stati loro a riempire la testa dei figli di aspettative illusorie di realizzazione sociale – così suona l’accusa che viene loro rivolta. Ma si può davvero parlare di colpa?
Accadeva questo, Accadrà questo, Accade questo: la scansione del romanzo in tre parti cronologicamente non consecutive confonde i piani temporali e aggroviglia la trama in un labirinto inestricabile, simile alla ricerca inconcludente di un lavoro da parte di Nero. Il presente viene continuamente rimandato, fino alla fine del libro. Intrappolato tra i ‘se’ e i ‘ma’ della sua impotenza, Nero trova sollievo soltanto nelle teorie del complotto, per cercare di dare un senso alla sua assurda condizione: «In realtà è già tutto molto più spaventoso di così, più difficile da accettare: i complotti ci rendono solo più comprensibile ciò che non è comprensibile». Peraltro, il nome stesso di Nero è stato scelto dalla madre per contrastare un presunto complotto per diffondere impunemente il nome Bianca, nato nei mesi successivi all’uscita dell’omonimo film di Nanni Moretti. Secondo la logica del complotto, se le cose vanno male, deve essere colpa di qualcuno, che così ha voluto. Gli imputati più ovvi per spiegare il disastro in cui i trentenni si trovano sono i genitori, appartenenti alla generazione dei boomer, che non capiscono o non vogliono vedere che cosa il mondo è diventato, ma che hanno sicuramente la loro parte di torto: sono stati loro a riempire la testa dei figli di aspettative illusorie di realizzazione sociale – così suona l’accusa che viene loro rivolta. Ma si può davvero parlare di colpa?
Un mondo in cui genitori, più o meno poveri, avevano fatto di tutto per far studiare i loro figli, nascondendo la loro fragilità, il loro bisogno di rimanere vivi, la rapina ininterrotta della realtà nei loro confronti, dietro menzogne di espansione occupazionale, miraggi di aumenti salariali progressivi, promesse di lieto fine a tempo indeterminato, e tutte queste fraudolente illusioni le dicevano in assoluta buonafede, ad alta voce, forse per coprire il rumore di fondo che minacciava la loro sicurezza, ottenendo come unico risultato dei loro investimenti che, alla fine degli studi, i loro figli si erano ritrovati più poveri di loro.
Forse quella speranza nell’avvenire dei figli era stata la forma di evasione dei genitori dalla realtà in cui vivevano. Senonché il padre di Nero, Livio, scompare per davvero, senza lasciare traccia. Nero intuisce che la sparizione dipende da qualcosa che è andato storto nel loro passato e decide, con l’aiuto dell’amica Elettra – tornata dall’estero per non perdere l’unica cosa che l’aiuta a stare in Italia: pensare di andarsene – di servirsi di una nuova invenzione per risolvere tutti i suoi problemi, familiari e lavorativi. Il governo Meloni ha infatti messo a punto una macchina del tempo per liberarsi dei disoccupati e degli immigrati, in modo da poter continuare a proclamare indisturbato il migliore dei mondi possibili. I pesi di cui la società vuole disfarsi vengono spediti nel passato, secondo un meccanismo pressoché infallibile. Il totem per saltare la fila nei Centri per l’impiego garantisce una ricollocazione immediata in un luogo e in un’epoca in cui il lavoro è garantito. Naturalmente, il sistema fa sì che il rischio di intervento sul presente attraverso eventuali modificazioni del passato sia ridotto a zero, attraverso rigidi protocolli di vigilanza e punizione delle anomalie, che fanno del viaggio nel tempo «una specie di gulag».

Il sistema si alimenta del tempo sprecato nel presente. Nel romanzo il tempo, un po’ come in Momo di Michael Ende, viene rubato alle persone dai grigi rappresentanti della burocrazia attraverso le estenuanti attese negli uffici pubblici: le ore perse nella compilazione di inutili scartoffie forniscono il carburante per la dislocazione dei disoccupati e degli extracomunitari nel passato. Eppure qualcosa può ancora andare storto persino in un meccanismo così ben congegnato. Infatti queste attese hanno un risvolto potenzialmente sovversivo: le pause forzate dall’attività potrebbero lasciare il tempo per pensare, elaborare una coscienza critica sui diritti propri e altrui, persino per passare all’azione. L’immigrato senegalese Malang, ad esempio, matura in uno di questi momenti morti la decisione di farsi inviare nel passato e piombare nell’infanzia di Giorgia Meloni, per inculcarle ideali antirazzisti e democratici. Nonostante il Centro temporale per l’impiego lo spedisca nel Missouri del 1959, il tentativo di raggiungere la piccola Giorgia gli riesce, circa vent’anni dopo; le conseguenze della sua impresa, tuttavia, non si lasciano apprezzare nel presente.
Il viaggio nel tempo si dimostra un fallimento: nient’altro che una fuga dalla realtà messa in atto dalla generazione di Nero
Anche Nero viene catapultato negli Stati Uniti del secondo dopoguerra, dominati da uno scadente immaginario capitalista, in cui John Wayne si scopre essere il dominus dei più mirabolanti complotti della storia – nessun ruolo per John Wayne, aveva promesso Vonnegut in Mattatoio n. 5, cui Giommoni dichiaratamente si ispira. Quest’esperienza fa crollare in chi legge l’illusione che la risposta ai problemi del presente possa venire dal passato. Alla prova dei fatti, il viaggio nel tempo si dimostra un fallimento: nient’altro che una fuga dalla realtà messa in atto dalla generazione di Nero. Con il presente, dunque, bisogna fare i conti, per quanto poco spazio il presente lasci all’azione. Pensarsi perdenti in partenza è in fondo fare il gioco di chi ha ordito il grande complotto, che non solo vuole garantirsi l’ubbidienza delle masse, ma anche distoglierle dall’unico elemento di vera contraddizione, che è l’esperienza o, se vogliamo, la vita: il contatto con gli altri esseri umani e con il mondo.
_-_liù_bosisio,_paolo_villaggio,_plinio_fernando.jpg)
La sferzata per cambiare prospettiva viene non a caso da un personaggio stravagante, ai limiti della follia, catapultato direttamente dal passato, che nel romanzo ha il nome di Ventottopercento, dalla provvigione sugli affari che costantemente reclama. Il pazzo si imbuca a una manifestazione sindacale nel 2012, dove riesce persino a prendere la parola.
Stimabile gente, se siete gli unici tanto coraggiosi da preoccuparvi della classe lavoratrice, allora, da questo palco, vi invito a esserlo ancora di più e prestare più attenzione alle persone che cercano lavoro perché, senza dubbio, i disoccupati sono le persone che lavorano di più al mondo e non si beccano neanche un soldo bucato. Impiegati, operai, funzionari lo si diventa alle otto di mattina e alle sei di sera si smette. Disoccupati lo si è tutto il giorno. Il disoccupato è un lavoro a tempo pieno, durante la pausa pranzo o in malattia o in ferie il disoccupato rimane sempre disoccupato. Vi chiedo quindi, amici miei: badate anche a questi instancabili lavoratori. Ricordatevi di loro, prendetevi cura anche di questi cinque milioni di anime che vengono chiamati esercito, anche se non conquistano nulla, anche se hanno già perso prima di combattere. Stimabile gente, costoro sono l’unico vero esercito pacifista!
Tutti sono sempre al lavoro, ma per le cause sbagliate. Anziché crogiolarsi nella speranza di trovare un impiego a tempo indeterminato, o nella fantasia di cambiare il passato, non si dedica mai abbastanza tempo a raccogliere e custodire ciò che in questo inferno distopico si può ancora salvare. La vita non è un lavoro, così come non lo è trovare sé stessi. Riconciliarsi con il proprio tempo, recuperando altri aspetti del proprio vissuto, è la risposta che Giommoni sembra opporre alla dittatura del lavoro: non a caso, nella relazione ritrovata tra Nero e il padre Livio stanno il cuore e lo scioglimento della vicenda romanzesca. Se per trovare il senso di sé è necessario viaggiare nel tempo, lo si faccia pure: purché alla fine si ritorni ad abitare nel presente, perché rinunciare a vivere il proprio tempo, ostaggi di vecchi film di John Wayne e fantasie in technicolor, sarebbe davvero il peggior complotto immaginabile. E non avrebbe altri colpevoli, se non le sue stesse vittime.

Commenta